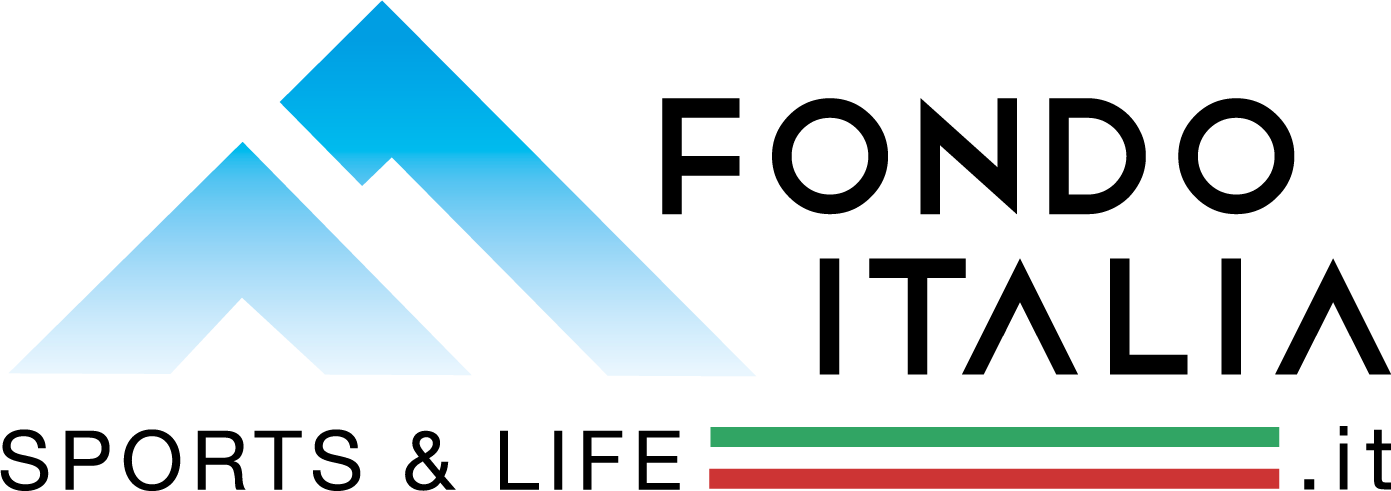“Io ho fatto un dieci per cento del lavoro, ho dovuto soltanto muovere le gambe e vincere”. Parole del campione del mondo sprint, Federico Pellegrino, che ha voluto ricordare quanto, in uno sport apparentemente individuale, ci sia un lavoro di squadra, nascosto alle telecamere. Quello di allenatori, tecnici, federazioni, skiman, massaggiatori e fisioterapisti. Il motore dell’atleta deve essere preparato alla perfezione per raggiungere dei grandi traguardi. Tra coloro che lavorano dietro le quinte ci sono dei grandissimi professionisti, come Erik Benedetto, fisioterapista piemontese (è nato ad Azeglio, in provincia di Torino) molto stimato nell’ambiente, che ha avuto un piccolo passato da atleta, prima di laurearsi in scienze motorie e fisioterapia, entrare nella nazionale italiana femminile, avere una piccola avventura con il Giappone e tornare in nazionale, questa volta maschile, insieme a Chenetti. Della sua carriera professionale e di tanto altro, abbiamo parlato con lui in questa intervista.
Ciao Erik. Partiamo dagli inizi: come mai hai deciso di lasciare la tua carriera da atleta per concentrarti sullo studio di scienze motorie e fisioterapia?
«Ho iniziato come atleta, raccogliendo anche dei buoni risultati ed entrando nel Centro Sportivo Esercito. Non ero, però, un campione, diciamo che arrivavo attorno alla quindicesima o ventesima posizione in Italia, ma non sono mai entrato in nazionale e non ho esordito in Coppa Europa. Mi difendevo, perché c’erano dei grandi campioni che andavano forte. Andavo meglio in pattinaggio che in classico. Dopo un anno nell’Esercito, dove ho conosciuto Paolo Riva che era mio allenatore, ho deciso di lasciare per seguire la mia grande passione, lo studio, così ho iniziato a studiare scienze motorie e fisioterapia».
L’essere stato un atleta, ti aiuta nel tuo lavoro attuale?
«Sicuramente mi permette di avere un approccio migliore con gli atleti. Ancora oggi cerco di sfogare il mio grande desiderio agonistico, partecipando ad alcune gare di corsa in montagna. Non sono stato un atleta di alto livello, ma conosco bene le dinamiche di una gara, avendole affrontate da protagonista. So cosa può sentire un atleta. In questi dodici anni di esperienza a seguito della Coppa del Mondo, prima con le donne per otto anni, poi con il Giappone e quindi con la nazionale maschile italiana, ho imparato tanto vedendo le gare, è aumentato il mio bagaglio di conoscenza. Riesco a comprendere meglio, per esempio, quale carico di allenamento possa sopportare un atleta e prevenire così eventuali infortuni».
Come sei arrivato alla nazionale italiana nel 2004?
«Quando ero ancora atleta, ho fatto il corso da allenatore, dove ho conosciuto Marco Albarello, il quale, stimandomi moltissimo, non appena è diventato responsabile della nazionale voleva inserirmi nell’organico, con l’obiettivo di ringiovanire lo staff. Mi chiamò la prima volta quando ancora ero al primo anno di fisioterapia, ma rinunciai perché volevo concentrarmi sullo studio. Lui non accetta mai un no, così mi cercò anche negli anni successivi e dopo altri due rifiuti, alla fine mi offrì un posto come fisioterapista della squadra femminile. Avevo quasi finito l’università, questo genere di offerta mi piaceva, così accettai e feci il mio primo ritiro quando dovevo ancora dare la tesi, in occasione della gara di Dusseldorf, una sprint che si faceva ad ottobre e rappresentava una sorta di prologo. Conquistammo anche due podi, con la Paruzzi nell’individuale, e sempre lei insieme a Follis nella team sprint. Non fosse stato per Albarello, non avrei mai avuto questa opportunità. Dopo otto anni, ho lasciato passando alla nazionale giapponese, nella quale facevo un po’ tutto, allenatore, fisioterapista e skiman, cercando di cambiare la loro programmazione. Anche quei due anni sono serviti molto. Infine, quando Chenetti è tornato in nazionale, mi ha voluto fortemente con la squadra maschile, cercava un fisioterapista che fosse anche preparatore atletico. Non ci ho pensato due volte, sapevo che con lui si poteva arrivare in alto. In questi anni, tutti gli allenatori mi hanno dato carta bianca sul lato della “forza” nella preparazione fisica. Così anche con Chenetti, ci occupiamo insieme della preparazione fisica e a me viene affidata la parte specializzata sulla forza».
Qual è il ricordo più bello della tua prima avventura italiana, quella nella squadra femminile?
«Il bronzo olimpico della staffetta a Torino 2006, perché tutte le medaglie di squadra sono quelle cui teniamo di più. Fu un grande risultato anche il terzo posto ottenuto a Oberstdorf, nei Mondiali dell’anno precedente. L’allenatore Gianfranco Pizio era un grande stratega, sapeva scegliere i quartetti. Poi sono particolarmente orgoglioso dell’oro vinto da Arianna Follis nei Mondiali del 2009, l’ultimo prima del successo ottenuto da Pellegrino a Lahti. Posso dire di essere stato protagonista di entrambi i successi (ride ndr)».
Come mai hai scelto di accettare l’offerta del Giappone?
«La nazionale giapponese era allenata dal valdostano Fabio Ghisafi, che era stato mio allenatore in Asiva. Quando mi trovavo con la nazionale italiana femminile mi chiedeva spesso consulenza circa i programmi e la forza. Così, non appena saputo che non lavoravo più per l’Italia, mi ha chiamato subito, perché aveva bisogno di una persona che gestisse gli allenamenti. Non fu un impegno impossibile, nel senso che non dovevo andare in Giappone e nemmeno seguire tutte le gare. Il mio lavoro consisteva nel mandare programmi di preparazione e seguire gli allenamenti, che si svolgevano spesso in Valle d’Aosta».
Hai trovato delle grandi differenze tra gli atleti italiani e quelli giapponesi?
«Dal punto di vista della mentalità degli atleti è completamente un altro mondo. I giapponesi si sfiniscono negli allenamenti, restano senza energie, bisogna costringerli a fermarsi. Loro, se non riescono a fare una cosa, perseverano fino a quando non gli dici che va bene. Ma quando c’è un programma da seguire, si migliora piano piano, non ci si arriva subito, così ero costretto a fermarli, ma loro sono dei perfezionisti all’ennesima potenza, fino a quando non sono sfiniti non mollano. Ancora oggi c’è un atleta giapponese con cui ho un ottimo rapporto, lo incito sempre in gara. Lui si allena da solo, utilizzando parte del programma di allenamento che avevo preparato io. Sono contento di aver lasciato qualcosa, perché prima si allenavano alla rinfusa, mentre noi italiani ci alleniamo meglio e in maniera scientifica».
A proposito, ci sono tantissimi allenatori, skiman o fisioterapisti italiani che lavorano per nazionali straniere: ciò significa che siete più bravi?
«Abbiamo un’ottima scuola. Tanti giovani atleti, che come me non sono riusciti a emergere, hanno continuato su questa strada per passione, sono diventati tecnici, oppure hanno seguito altri percorsi sempre legati al mondo dello sport e in questo caso del fondo. Hanno seguito le orme di chi li ha preceduti, una tradizione fatta di grandi skiman e allenatori, perché abbiamo alle spalle una scuola molto valida. I tecnici italiani, rispetto a quelli di altre nazioni, sono in continuo aggiornamento, si confrontano, scambiano spesso idee, vogliono sempre migliorare e sono quindi ricercati. Questo perché, non avendo un grande bacino d’utenza, dobbiamo sfruttare al massimo delle possibilità quello che abbiamo, siamo molto più attenti rispetto agli altri, perché dobbiamo raccogliere il più possibile. I norvegesi, invece, hanno tantissimi atleti e il campione lo trovano già pronto, mentre noi dobbiamo crearlo ed essere estremamente bravi nel farlo. Dobbiamo per forza ricercare il massimo da ogni atleta e questo ci fa crescere, perché osserviamo i video degli altri e siamo in ricerca continua. Per esempio Chenetti ha portato idee innovative dal punto di vista tecnico, alle quali gli altri arriveranno soltanto tra qualche anno. È una persona avanti coi tempi, coglie delle cose che gli altri nemmeno hanno captato e ci ha fatto fare il salto di qualità. Ha inventato praticamente una nuova tecnica».
Qual è stato il momento più bello da quando sei tornato in Italia?
«La soddisfazione più grande l’ho avuta quando Chicco (Pellegrino ndr) ha vinto la sua prima gara in carriera. Non so descrivervi nemmeno cosa abbia provato in quel momento, era fantastico essere presente al suo primo successo, essendo io suo fisioterapista e preparatore. Ovviamente ci metto anche l’oro di Lahti, così come la team sprint di Falun, quando vinse il bronzo insieme a un bravissimo Diddi Nöckler. Poi sono stato felicissimo quando Francesco De Fabiani ha vinto in Coppa del Mondo a Lahti, quasi non ci potevo credere, vista la sua giovanissima età».
Che tipo di rapporto instauri con gli atleti?
«Ottimo, perché c’è un ambiente bellissimo, ridiamo, scherziamo e ci facciamo battute tra noi. È importante, in quanto è fondamentale che tra fisioterapista e atleta si instauri un rapporto di fiducia estrema, perché loro devono mettersi nelle tue mani, seguire i consigli che gli dai. In qualche modo li aiuto a sfogare la tensione, li ricarico, ogni giorno gli faccio il trattamento più utile in quel momento. Io cerco di dare tantissimo, provo anche a caricarli in qualche modo e, quando ottengono delle vittorie, le sento anche un po’ mie. Bisogna sempre saper usare la parola giusta, che possa stimolarli e dargli la carica. Per me è una soddisfazione enorme vedere quanto si fidino di me e ascoltino i miei consigli. Non sono un motivatore, quello è il lavoro degli psicologi, ma li carico a modo mio, perché a volte gli faccio fare dei lavori che sono più utili mentalmente che fisicamente. Per esempio, solitamente faccio un trattamento a Pellegrino tra la qualifica e le batterie, ma il giorno della sprint mondiale, avevo la netta sensazione che avesse i muscoli in grandissime condizioni. Ero certo che avrebbe vinto l’oro, così gli ho fatto fare un piccolo lavoro, ma che serviva più a lui mentalmente, perché volevo fargli capire che stava benissimo. A volte si fanno delle piccole cose per trasmettere una maggiore convinzione all’atleta. Quel giorno Chicco poteva fare dieci prove e non avrebbe mai sentito la fatica».
Quale ritieni sia l’allenamento giusto nel fondo moderno?
«Con Sepp (Chenetti ndr) abbiamo sempre fatto un gran lavoro sulle gambe sia nel gesto specifico sia con un lavoro in palestra che si basa su grandi sovraccarichi, perché gli arti inferiori sono fondamentali per il fondista attuale. È importante fare sia un lavoro sugli sci o skiroll sia in palestra con i pesi. Inoltre, visto che oggi si spinge molto con le braccia, è necessario allenare in modo specifico gli addominali, perché è fondamentale avere forza muscolare sul tronco, in quanto maggiore è la sua forza, più le braccia spingono».
Nell’ultimo anno hai lavorato moltissimo anche per aiutare Francesca Baudin a recuperare dall’infortunio alla caviglia.
«Lei rappresenta la più grande soddisfazione che ho avuto quest’anno, insieme alla medaglia d’oro di Pellegrino. Il suo successo agli Assoluti nella sprint in pattinaggio è stato particolarmente emozionante per me, perché fino a pochi mesi prima questa atleta non riusciva nemmeno a muovere un passo in skating. È stato un motivo d’orgoglio per me essere riuscito ad aiutarla, insieme a Saba, nel recuperare dall’infortunio alla caviglia, riuscendo anche a farle ottenere dei risultati, soprattutto pensando al fatto che, quando avevamo cominciato a lavorarci nell’aprile 2016, era in grande difficoltà e non poteva correre».
Insomma il ruolo del fisioterapista, pur stando dietro ai riflettori, è molto importante.
«Quello del fisioterapista è proprio un lavoro oscuro, siamo sempre dietro le quinte, ma abbiamo un carico di lavoro notevole. Abbiamo un ruolo fondamentale, perché oggi gli atleti sono come vetture di Formula 1, devono essere al top dopo ogni allenamento e così vengono da noi giustamente per qualsiasi fastidio, dovendo sempre dare il massimo. In questo senso la nostra attività è cambiata moltissimo negli anni».
Poi ci sono gli infortuni. Per esempio siete riusciti a recuperare Pellegrino in poche settimane, dopo l’infortunio che aveva accusato a Davos alla vigilia della Coppa del Mondo.
«Si era fatto male, così gli abbiamo fatto fare un lavoro in piscina, seguito passo per passo. Non è stato facile, soprattutto per lui, perché vedeva gli altri sciare e lui non poteva, ma ce l’abbiamo fatta. Quando ci sono queste situazioni nelle quali un atleta subisce un infortunio, noi dobbiamo tirare fuori tutto il bagaglio che abbiamo accumulato in anni di esperienza. Questo ti fa crescere, perché ogni atleta ha delle problematiche diverse e si impara tanto da loro. Ognuno di questi atleti mi ha fatto migliorare professionalmente, grazie a tanti di loro ho scoperto sul campo delle cose, che, probabilmente, avrei capito molto più tardi. È un continuo interscambio tra fisioterapista e atleta. Anche per questo è un vero privilegio lavorare per la nazionale italiana».
L’ultima domanda riguarda Elisa Brocard, tua compagna di vita. Le dai mai dei consigli su come lavorare?
«Lei, oggi, è allenata da Paredi, con il quale, conoscendola io molto bene, ho un interscambio di idee circa il suo programma, soprattutto nella parte riguardante la forza. Io le do dei consigli, ma sempre in accordo con Paredi, perché è lui che tira le fila, si occupa di lei e l’allena. In palestra, però, ogni tanto mi diverto a bacchettarla un po’ (ride ndr). A parte gli scherzi, sono davvero contento per i risultati che ha raggiunto nell’ultima stagione, se li merita».